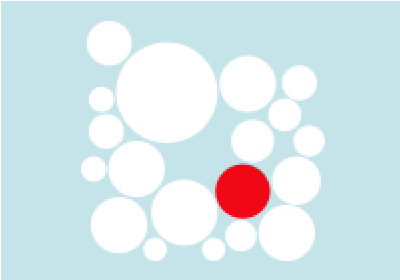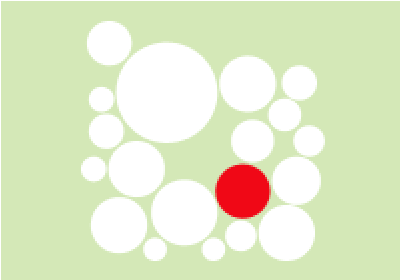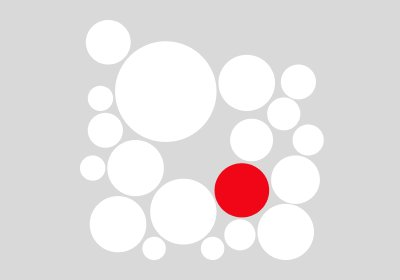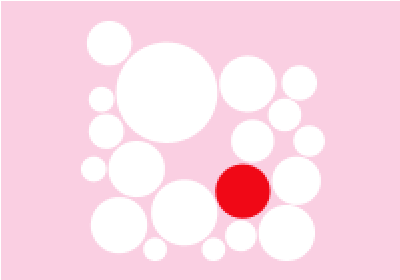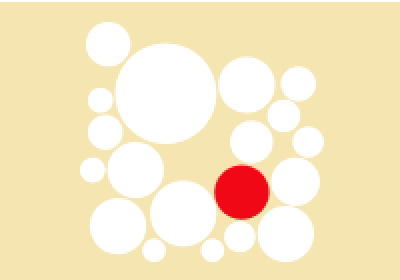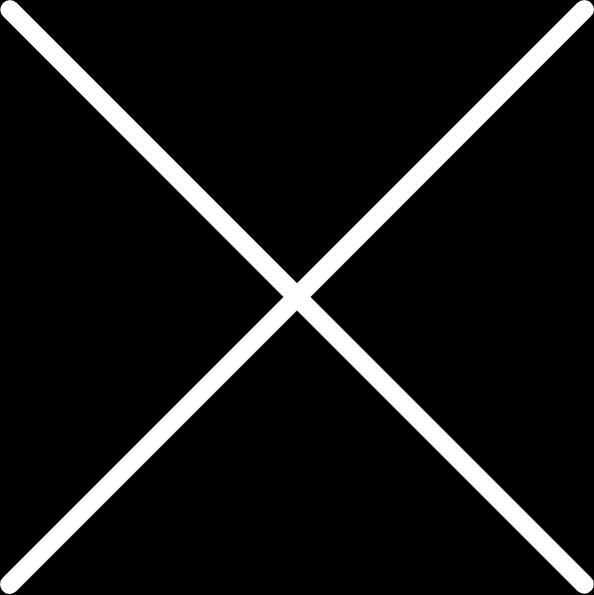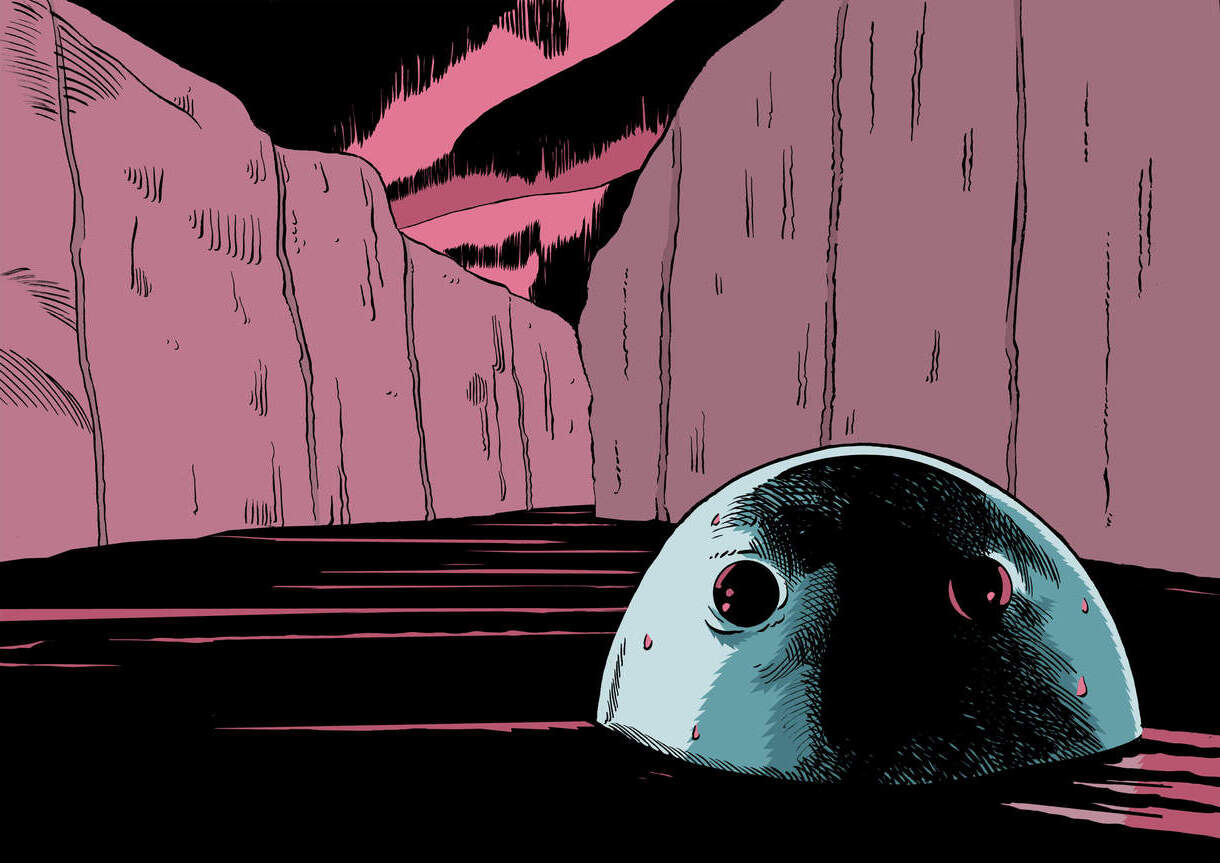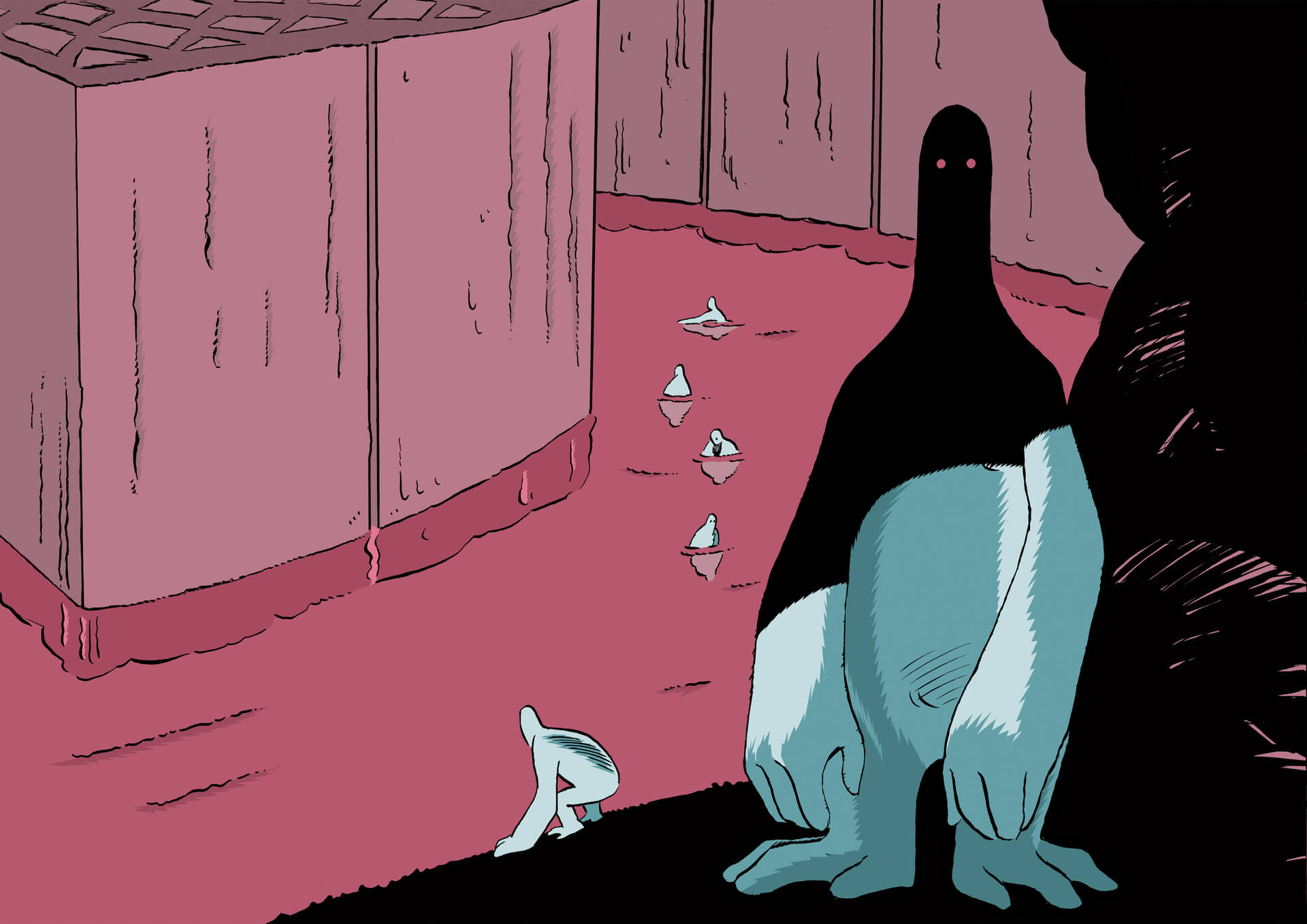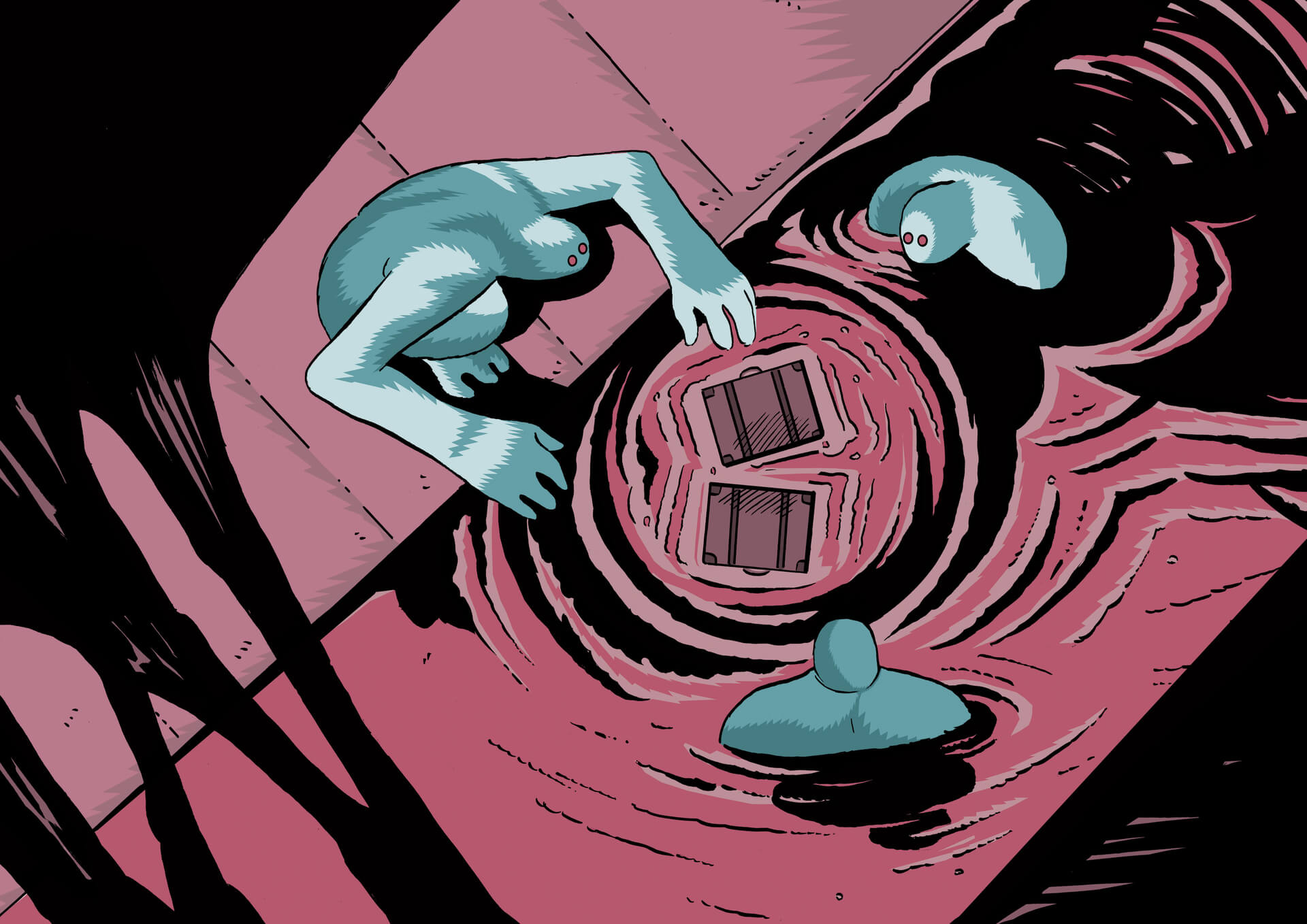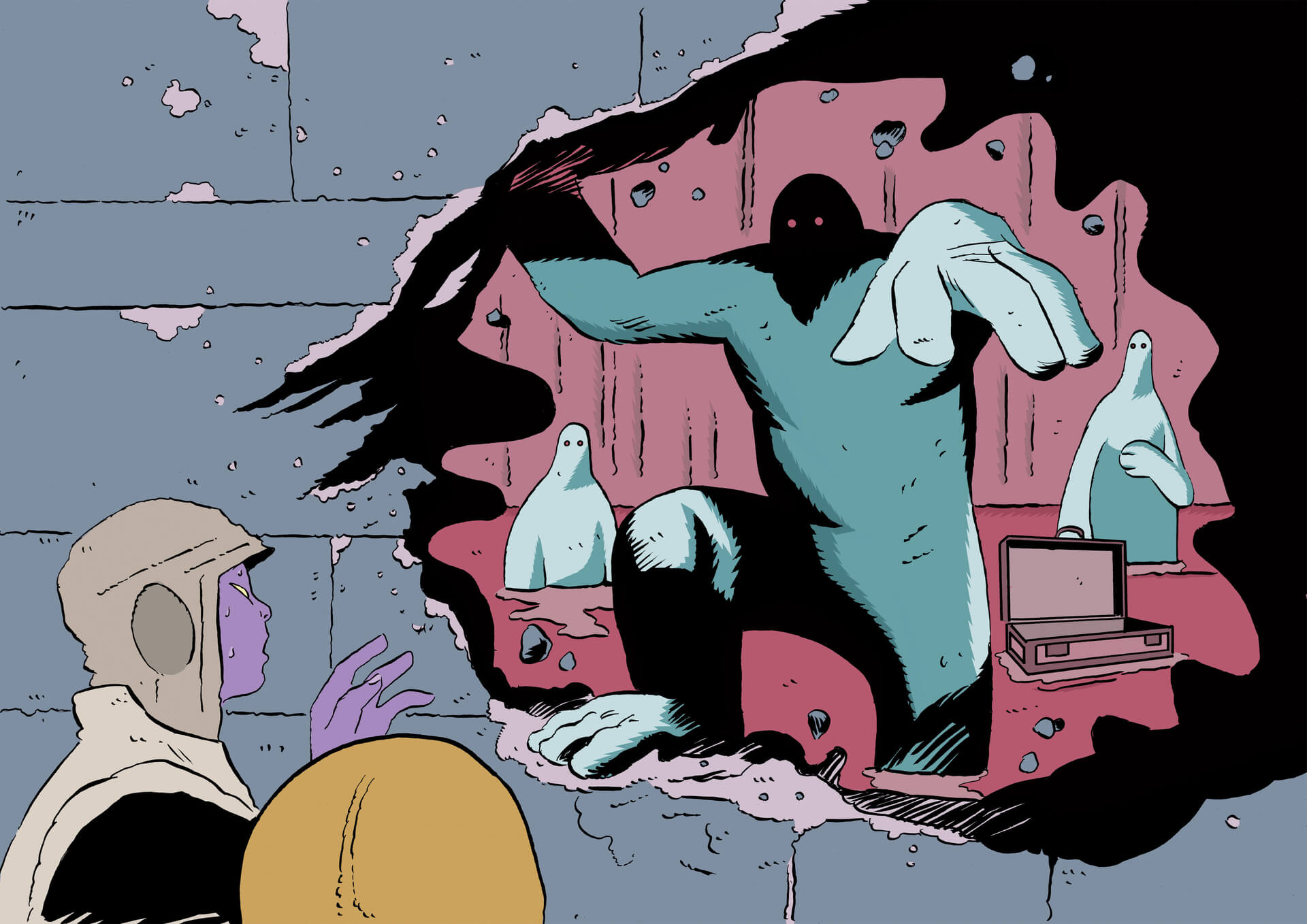TERAPIE AVANZATE
Diabete, la corsa per il trapianto "perfetto"
Già oggi, su pazienti diabetici selezionati, è possibile trapiantare le "isole pancreatiche", fondamentali per la produzione di insulina. I risultati sono buoni, ma non durano a lungo nel tempo. Una tecnica americana apre nuove speranze.

di Giovanni Sabato
Una ricerca del Massachusetts General Hospital di Boston (Stati Uniti), pubblicata sull’American Journal of Transplantation, apre nuove prospettive per i trapianti delle isole pancreatiche, che contengono le cellule beta, quelle che producono l’insulina: una via che si batte da tempo per affrancare dal bisogno di insulina i diabetici, e in particolare quelli con il diabete di tipo 1, in cui una reazione autoimmune distrugge le cellule beta.
Le isole - microscopici grumi di cellule contenenti le cellule beta - vengono prelevate e purificate, di norma, dal pancreas di un donatore, e poi iniettate con un semplice intervento nella vena porta del fegato del paziente, dove vanno a impiantarsi e producono l’insulina. Ma come in tutti i trapianti è poi necessaria una terapia immunosoppressiva, i cui effetti collaterali rendono l’intervento giustificato solo in un numero limitato di casi. Le isole pancreatiche, inoltre, non sempre funzionano bene, o smettono di farlo dopo alcuni anni. La tecnica sperimentata a Boston promette di aumentare il successo di questi trapianti, nel tempo, e di ridurre o evitare il bisogno di immunosoppressori.
«Il trapianto di isole pancreatiche è disponibile da oltre vent’anni, e grazie ai miglioramenti conseguiti è oggi un’opzione terapeutica concreta, seppure riservata a un piccolo numero di pazienti selezionati» - spiega Federico Bertuzzi, dirigente medico diabetologo all’Ospedale Niguarda di Milano, uno dei pochi centri che praticano l’intervento.
In Italia oltre al Niguarda lo esegue l’ospedale San Raffaele, sempre a Milano, anche se altri centri ci hanno lavorato e potrebbero praticarlo nei prossimi anni, mentre in Svizzera il centro di riferimento è quello guidato da Thierry Berney all’Università di Ginevra.
«I candidati sono pazienti con diabete di tipo 1 che ricevono già una terapia immunosoppressiva per altri motivi, come trapianti o altre malattie autoimmuni, o che devono ricevere il trapianto combinato delle isole pancreatiche e di un altro organo come rene o fegato, essendo per varie ragioni controindicato in loro il trapianto di pancreas» - aggiunge Bertuzzi. O, ancora, il trapianto di isole pancreatiche è indicato nel cosiddetto diabete instabile, quando il controllo glicemico è scarso e magari ci sono complicanze acute come ipoglicemie non avvertite, o episodi di chetoacidosi (una complicazione in cui il metabolismo di grassi e zuccheri è molto alterato con conseguenze anche molto gravi) e sebbene i malati siano seguiti con molta attenzione, ricorrendo a tutte le opzioni terapeutiche disponibili, non si ottiene un compenso glicemico adeguato. In rari casi il trapianto è proposto nel diabete di tipo 2, in cui inizialmente la produzione di insulina non è ridotta, ma nel tempo il pancreas può andare incontro a una sorta di esaurimento funzionale.
I RISULTATI - «Quanto ai risultati, in Italia siamo in linea con le casistiche europee e nordamericane» - spiega Bertuzzi. A tre-cinque anni dal trapianto, le isole continuano a funzionare bene nel 50-60% dei pazienti, che continuano a non aver bisogno di insulina. Dopo ancora alcuni anni una parte di costoro ha bisogno di un po’ di insulina, perché il trapianto inizia a funzionare meno, e in seguito la sua funzione si esaurisce e occorre un nuovo trapianto. «Considerato che è un intervento poco invasivo, che si fa in anestesia locale, ripeterlo non è un grosso problema» - osserva Bertuzzi.
Le isole pancreatiche si prelevano da cadavere, e - visti i pochi interventi che si fanno oggi - la loro disponibilità non è un problema. Gli sforzi che si fanno per migliorare la tecnica sono invece indirizzati a ridurre il bisogno della terapia immunosoppressiva, con i suoi effetti indesiderati, e di far durare di più le isole.
I SITI ALTERNATIVI - Una delle vie su cui si lavora sono siti (cioè punti del corpo) alternativi in cui iniettare le isole. «Nel fegato, attraverso la vena porta, le isole vanno nel letto vascolare (cioè all’interno dei vasi sanguigni, ndr) e ricevono subito ossigeno; ma si produce una reazione infiammatoria per cui si perde una massa significativa di cellule trapiantate». Perciò si stanno studiando siti diversi che permettano di evitare questo danno, e che un giorno possano essere adatti ad accogliere le isole contenute entro una capsula che le preservi dall’attacco immunitario, quando questa nuova tecnologia sarà disponibile.
Al San Raffaele di Milano si sta sperimentando il trapianto delle isole nel midollo osseo, e finora sono stati pubblicati alcuni lavori sull’autotrapianto. In pratica, nei malati di pancreatite cronica a cui bisogna asportare il pancreas, si prelevano da questo un po’ di isole, che si reimpiantano poi nel midollo della persona stessa.
«Noi al Niguarda, e un gruppo svedese legato al Karolinska Institutet, stiamo provando l’impianto nel muscolo, un sito interessante, proprio perché permetterebbe di usare le capsule - dice Bertuzzi. - Un terzo sito in sperimentazione è l’omento, cioè la membrana ricca di grasso che riveste l’intestino (e che appare adatta a ospitare dispositivi protettivi): Camillo Ricordi ha avuto le autorizzazioni e ora sta iniziando le sperimentazioni».
PROTEGGERE LE ISOLE - Accorgimenti per proteggere le isole pancreatiche dalla reazione immune, come le capsule, sono appunto l’altro filone di ricerca su cui si punta. Inglobando le isole in materiali gelatinosi che lasciano passare l’insulina, i nutrienti e altre sostanze, ma le proteggono dall’attacco immunitario, nei topi con diabete si sono ottenuti ottimi risultati. Le capsule, però, nel tempo scatenano una reazione infiammatoria: l’organismo riconosce la presenza estranea e, anche se non riesce a uccidere le isole all’interno, ingloba il tutto in una massa cicatriziale fibrosa, così che alla fine le isole non funzionano più. «Evitare questa risposta modulando la reazione immunitaria potrebbe essere una via di successo, ed è questo che hanno fatto i ricercatori di Boston» - spiega Bertuzzi.
Più precisamente, i ricercatori americani hanno aggiunto alle capsule una cosiddetta chemochina, la proteina CXCL12, che sopprime la risposta immunitaria (allontanando i linfociti T effettori che attaccano le cellule, e reclutando, invece, linfociti T dal ruolo soppressorio) e favorisce la sopravvivenza delle isole. E la cosa ha funzionato, permettendo alle isole pancreatiche di resistere e funzionare a lungo.
«La rivista su cui hanno pubblicato il lavoro è molto seria e l’uso della chemochina per interferire nella risposta infiammatoria è una strategia interessante - aggiunge Bertuzzi. - Certo, nei topi è abbastanza facile guarire il diabete, ma la difficoltà sta poi nel passaggio a grandi organismi come l’uomo. Ma è comunque uno studio importante, perché apre un nuovo settore di ricerca: abbinare l’effetto protettivo delle capsule a quello di immunomodulazione, ottenendo con un unico strumento il duplice vantaggio di avere un effetto barriera e modulare la risposta immunitaria. Con questo approccio - conclude Bertuzzi - siamo ancora agli studi animali e serviranno anni per dimostrare che questa tecnica sia utilizzabile anche per gli esseri umani. Ma sono in corso parecchie altre sperimentazioni sui pazienti, per ridurre il bisogno di immunosoppressione con varie strategie, e non è detto che una di queste non abbia successo in tempi brevi. Quindi non abbiamo alcuna certezza, ma se siamo fortunati entro pochi anni potremmo già avere una terapia più efficace».
Data ultimo aggiornamento 2 aprile 2015
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco